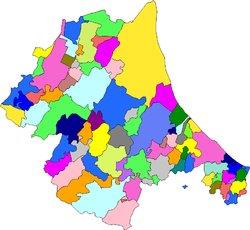Dotto. Ma anche scanzonato e irriverente. Insolito reportage gastronomico nella terra del Sangiovese
di Gian Paolo Bonomi
 Propormi di andare in Romagna? à come invitare unâoca a bere! Alla pascoliana terra del Sangiovese andrei anche a piedi (e la stanchezza di vivere in una Milano ormai vocata solo ai danèe è lâultima delle motivazioni), figuriamoci se comodamente seduto su unâauto (con qualcun altro al volante, visto che guidare sullâautostrada â come diceva il Passatore – mi rompe i maroni, e sulle strade statali odio finire cuccato per eccesso di velocità da vigili che ti depredano legalmente â nulla rischiando, a differenza del sullodato Robin Hood rumagnòl â solo per rianimare il c/c del loro Comune). Ma perché tanta aficiòn romagnola? Dâaccordo, mio padre era di Lugo, quindi nel deep south della Romagna â Emilia (più che allâordine alfabetico, ritengo più equo assegnare le precedenze allâimportanza). Ma, figlio di madre novarese, avrei anche potuto affezionarmi al Piemonte (oltretutto fui portato a nascere a Torino, e lì fortunatamente mi andò di lusso non divenendo juventino) terra seriosa che, beninteso, stimo e apprezzo (Barolo, Barbaresco. Barbera) però non riesco ad amare visceralmente. Le ragioni? Va a sapere o, forse, perché i miei semi paìs piemontesi han dato ricetto per troppo tempo a quei pidocchiosi â non lo dico io, fu il Giuanìn Brera a scriverlo â dei Savoia, mentre, si sa, la Romagna è fieramente non meno che totalmente repubblicana (tantâè che sulla scalinata del municipio di Ravenna una lapide rammenta che il 2 giugno del â46 per la Ripoblica votarono in più di 40.000 e per la monarchia solo pochi intimi).
Propormi di andare in Romagna? à come invitare unâoca a bere! Alla pascoliana terra del Sangiovese andrei anche a piedi (e la stanchezza di vivere in una Milano ormai vocata solo ai danèe è lâultima delle motivazioni), figuriamoci se comodamente seduto su unâauto (con qualcun altro al volante, visto che guidare sullâautostrada â come diceva il Passatore – mi rompe i maroni, e sulle strade statali odio finire cuccato per eccesso di velocità da vigili che ti depredano legalmente â nulla rischiando, a differenza del sullodato Robin Hood rumagnòl â solo per rianimare il c/c del loro Comune). Ma perché tanta aficiòn romagnola? Dâaccordo, mio padre era di Lugo, quindi nel deep south della Romagna â Emilia (più che allâordine alfabetico, ritengo più equo assegnare le precedenze allâimportanza). Ma, figlio di madre novarese, avrei anche potuto affezionarmi al Piemonte (oltretutto fui portato a nascere a Torino, e lì fortunatamente mi andò di lusso non divenendo juventino) terra seriosa che, beninteso, stimo e apprezzo (Barolo, Barbaresco. Barbera) però non riesco ad amare visceralmente. Le ragioni? Va a sapere o, forse, perché i miei semi paìs piemontesi han dato ricetto per troppo tempo a quei pidocchiosi â non lo dico io, fu il Giuanìn Brera a scriverlo â dei Savoia, mentre, si sa, la Romagna è fieramente non meno che totalmente repubblicana (tantâè che sulla scalinata del municipio di Ravenna una lapide rammenta che il 2 giugno del â46 per la Ripoblica votarono in più di 40.000 e per la monarchia solo pochi intimi).
 Oltretutto, âtornoâ in Romagna quasi sempre in compagnia dal mè amìs Paolo, che, lui sì (a fronte dello scrivente, semplice meticcio) è lughese doc 100% (e come me, di Milano salva ormai solo il Camparino e quelle rare mescite di vino in cui bevi bene e non ti fottono con la modaiola Happy Hour, in cui paghi una cifra per un solo calice e gli avanzi del ristorante di fianco). E oltre al piacere di scoprire con un amico la terra solatia dei Guidi e Malatesta, durante le zingarate romagnole Paolo mi fa tanto sentire come il generale Custer (lui girava nel West coi gli scouts Sioux addetti alle traduzioni, io mi avvalgo di Paolo a mò di Berlitz con gli indigeni di Forlì e Brisighella, perché provate voi a capirlo, il romagnolo, soprattutto quando viene sibilato con quella Z che pare una scudisciata).
Oltretutto, âtornoâ in Romagna quasi sempre in compagnia dal mè amìs Paolo, che, lui sì (a fronte dello scrivente, semplice meticcio) è lughese doc 100% (e come me, di Milano salva ormai solo il Camparino e quelle rare mescite di vino in cui bevi bene e non ti fottono con la modaiola Happy Hour, in cui paghi una cifra per un solo calice e gli avanzi del ristorante di fianco). E oltre al piacere di scoprire con un amico la terra solatia dei Guidi e Malatesta, durante le zingarate romagnole Paolo mi fa tanto sentire come il generale Custer (lui girava nel West coi gli scouts Sioux addetti alle traduzioni, io mi avvalgo di Paolo a mò di Berlitz con gli indigeni di Forlì e Brisighella, perché provate voi a capirlo, il romagnolo, soprattutto quando viene sibilato con quella Z che pare una scudisciata).
 Ma dove vado, quando lascio (ahimè solo provvisoriamente ma contento) Milano e arrivo in Romagna dopo doverosi pit-stop di Lambrusco e Culatello (da cui si evince che anche lâEmilia mi piace assai, anche se quei balossi degli indigeni definiscono spregiativamente i rumagnol âi bagniniâ, però, poi vengono a divertirsi a Remmìn e Rizziòne)? Beh, câè solo lâimbarazzo della scelta, tanto, ovunque tu vada non fai fatica a trovare un bicchiere di Sangiovese (Bacchelli suggerì come, se ti perdi, non faticare per sapere in quale delle âdue regioniâ ti ritrovi: entri in un casolare, chiedi da Bè e se sei in Emilia ti portano acqua, in Romagna ti porgono il vino). E mi riferisco al Sangiovese, che poi sarebbe uno dei (soli) tre santi in cui credo (gli altri due? San Fermìn, quello che a Pamplona mi protegge durate le fiestas, e San Siro, beninteso quello di rito interista). Problemi, dicevo, di dove andare una volta giunto in quella che il conte Rognoni di Cesena (grande personaggio, non solo dello sport) definì la Libera Repubblica di Romagna, non ne ho. Oltretutto (elementare, Watson, dopo una vita che vi bazzichi) non si contano i numi tutelari che rendono viepiù piacevoli e goduriose le mie apparizioni laddove si esibì il bravo Passatore (Boncellino, un tiro di schioppo da Lugo, e poco distante era nato il suo gregario alias Dumandò solo perché curioso e voglioso di sapere).
Ma dove vado, quando lascio (ahimè solo provvisoriamente ma contento) Milano e arrivo in Romagna dopo doverosi pit-stop di Lambrusco e Culatello (da cui si evince che anche lâEmilia mi piace assai, anche se quei balossi degli indigeni definiscono spregiativamente i rumagnol âi bagniniâ, però, poi vengono a divertirsi a Remmìn e Rizziòne)? Beh, câè solo lâimbarazzo della scelta, tanto, ovunque tu vada non fai fatica a trovare un bicchiere di Sangiovese (Bacchelli suggerì come, se ti perdi, non faticare per sapere in quale delle âdue regioniâ ti ritrovi: entri in un casolare, chiedi da Bè e se sei in Emilia ti portano acqua, in Romagna ti porgono il vino). E mi riferisco al Sangiovese, che poi sarebbe uno dei (soli) tre santi in cui credo (gli altri due? San Fermìn, quello che a Pamplona mi protegge durate le fiestas, e San Siro, beninteso quello di rito interista). Problemi, dicevo, di dove andare una volta giunto in quella che il conte Rognoni di Cesena (grande personaggio, non solo dello sport) definì la Libera Repubblica di Romagna, non ne ho. Oltretutto (elementare, Watson, dopo una vita che vi bazzichi) non si contano i numi tutelari che rendono viepiù piacevoli e goduriose le mie apparizioni laddove si esibì il bravo Passatore (Boncellino, un tiro di schioppo da Lugo, e poco distante era nato il suo gregario alias Dumandò solo perché curioso e voglioso di sapere).
 Tra i pii che tra collina, coste e pianura del pianeta Romagna tuttora mi rivolgono la parola mi vanto di annoverare (ça va sans dire quasi tutti bazzicanti i Viaggi&Turismo nonché il giornalismo gastronomico): i coniugi Dolcini in quel di Predappio, Vanni e Lina da una vita corifei di quella terra, e che meraviglia quella loro casa collinare (quando ci penso vorrei tornare ⦠e vai col lìssio); Bruna, facente viaggiare a Ravenna; Maria Teresa, da Cattolica mio informatore sul porsùt di Carpegna; a Forlì oltre che dotta prof universitaria la Gloria Bazzocchi è sorella nerazzurra del locale Inter Club; e Davide Paolini (Santa Sofia) è quel grande giornalista (Il Sole 24Ore, gastronauta) che mi ha inserito nella Storia definendomi massimo conoscitore italico del Pata Negra iberico. Già , il magnèr, mangiare. E rieccomi in giro col mio scout Paolo nonché vicino di tomba (appunto in quel di Lugo) io vicino a quella di Longanesi, lui a quella di Baracca (che da lustri tenta di scimmiottare tentando, invano, di sollevarsi su precari deltaplani).
Tra i pii che tra collina, coste e pianura del pianeta Romagna tuttora mi rivolgono la parola mi vanto di annoverare (ça va sans dire quasi tutti bazzicanti i Viaggi&Turismo nonché il giornalismo gastronomico): i coniugi Dolcini in quel di Predappio, Vanni e Lina da una vita corifei di quella terra, e che meraviglia quella loro casa collinare (quando ci penso vorrei tornare ⦠e vai col lìssio); Bruna, facente viaggiare a Ravenna; Maria Teresa, da Cattolica mio informatore sul porsùt di Carpegna; a Forlì oltre che dotta prof universitaria la Gloria Bazzocchi è sorella nerazzurra del locale Inter Club; e Davide Paolini (Santa Sofia) è quel grande giornalista (Il Sole 24Ore, gastronauta) che mi ha inserito nella Storia definendomi massimo conoscitore italico del Pata Negra iberico. Già , il magnèr, mangiare. E rieccomi in giro col mio scout Paolo nonché vicino di tomba (appunto in quel di Lugo) io vicino a quella di Longanesi, lui a quella di Baracca (che da lustri tenta di scimmiottare tentando, invano, di sollevarsi su precari deltaplani).
 Specialità di Paolo sono i Capaltaz, grossi tortelloni che regolarmente, allâinizio di ogni inverno, assicura di voler elaborare e cucinare (ma, pigrissimo, sono ormai ventâanni che non finanzia la Fernet Branca). Perché questo primo piatto (che poi vale tutto un pasto) della collina romagnola è spaventosamente pesante, di cui alla ricetta: impasto di farine possibilmente variè e acqua, ripieno di castagne bollite e mostarda senapata, dopo bollitura siano conditi con pane grattato, olio e pepe (se non bastasse il Fernet câè sempre lâAlka Seltzer). Meno letali sono invece di Passatelli (facili, li so fare anchâio, e sovente meglio di Paolo): metà pane grattato, metà forma (nel senso di grana grattugiato) e un uovo a cranio, il tutto passato (escono grossi spaghetti) attraverso un curioso strumento bucherellato (si trova sulle bancarelle
Specialità di Paolo sono i Capaltaz, grossi tortelloni che regolarmente, allâinizio di ogni inverno, assicura di voler elaborare e cucinare (ma, pigrissimo, sono ormai ventâanni che non finanzia la Fernet Branca). Perché questo primo piatto (che poi vale tutto un pasto) della collina romagnola è spaventosamente pesante, di cui alla ricetta: impasto di farine possibilmente variè e acqua, ripieno di castagne bollite e mostarda senapata, dopo bollitura siano conditi con pane grattato, olio e pepe (se non bastasse il Fernet câè sempre lâAlka Seltzer). Meno letali sono invece di Passatelli (facili, li so fare anchâio, e sovente meglio di Paolo): metà pane grattato, metà forma (nel senso di grana grattugiato) e un uovo a cranio, il tutto passato (escono grossi spaghetti) attraverso un curioso strumento bucherellato (si trova sulle bancarelle  al mercato di Lugo il mercoledì, in assenza va bene un passapurè) e fatto cadere in un (buon) brodo (chi conosce cosâè il cappone ha capito tutto). Non senza premettere che le Tajadèl (tagliatelle) della Benilde a Bertinoro restano somme (ancorchè le sciurette milanesi storceranno il naso alla vista dellâumile locale), se si passa ai secondi riecco Paolo esperto di E Castrè (il castrato) che gli stolti schizzinoosi snobbano per la povertà della genìa e invece è saporitissima carne (e più che alla brace, lì finisca la bacchetta, il mio scout ne cucina lo spezzatino in gustoso umido, il tutto non privo di insaporente, romagnolissimo Scalogno). Altri piacevoli (ma, come giusto, un filino ruvidi) sapori? Glissato sulla Piè/piada, piadina (e in Romagna â Emilia esiste un, minimo, centinaio
al mercato di Lugo il mercoledì, in assenza va bene un passapurè) e fatto cadere in un (buon) brodo (chi conosce cosâè il cappone ha capito tutto). Non senza premettere che le Tajadèl (tagliatelle) della Benilde a Bertinoro restano somme (ancorchè le sciurette milanesi storceranno il naso alla vista dellâumile locale), se si passa ai secondi riecco Paolo esperto di E Castrè (il castrato) che gli stolti schizzinoosi snobbano per la povertà della genìa e invece è saporitissima carne (e più che alla brace, lì finisca la bacchetta, il mio scout ne cucina lo spezzatino in gustoso umido, il tutto non privo di insaporente, romagnolissimo Scalogno). Altri piacevoli (ma, come giusto, un filino ruvidi) sapori? Glissato sulla Piè/piada, piadina (e in Romagna â Emilia esiste un, minimo, centinaio  di altri modi per chiamare âsto plurimillenario mangiare) non resta che passare al dessert. Leggasi Fichi giulebbati e Squaquerone (stracchino da vacche stracche, quindi meglio in primavera) e in Romagna (con tutto quel ben di dio di frutta ivi raccolta) fanno bene financo la crostata. Qui giunti non resta che ricordare che sul magnifico pianeta romagnolo aleggia la Bibbia mangereccia nazionale (Pellegrino Artusi, di Forlimpopoli/Frampùl, âLâArte di Mangiar Beneâ, e non si perda in giugno un Certamen aperto ai cuochi dilettanti). Ma si corra subito ad acquistare anche il Vangelo gastronomico del (altrettanto) rumagnòl Olindo Guerrini alias Lorenzo Stecchetti (SantâAlberto, Ravenna) leggasi âLâarte di utilizzare gli Avanzi della Mensaâ. Letteratura suggerita da Paolo, mio scout nonché lughese doc (che pertanto prima o poi imparerà a âfare i Passatelliââ¦). www.romagna.com
di altri modi per chiamare âsto plurimillenario mangiare) non resta che passare al dessert. Leggasi Fichi giulebbati e Squaquerone (stracchino da vacche stracche, quindi meglio in primavera) e in Romagna (con tutto quel ben di dio di frutta ivi raccolta) fanno bene financo la crostata. Qui giunti non resta che ricordare che sul magnifico pianeta romagnolo aleggia la Bibbia mangereccia nazionale (Pellegrino Artusi, di Forlimpopoli/Frampùl, âLâArte di Mangiar Beneâ, e non si perda in giugno un Certamen aperto ai cuochi dilettanti). Ma si corra subito ad acquistare anche il Vangelo gastronomico del (altrettanto) rumagnòl Olindo Guerrini alias Lorenzo Stecchetti (SantâAlberto, Ravenna) leggasi âLâarte di utilizzare gli Avanzi della Mensaâ. Letteratura suggerita da Paolo, mio scout nonché lughese doc (che pertanto prima o poi imparerà a âfare i Passatelliââ¦). www.romagna.com