Testo e foto di Franca Dell’Arciprete
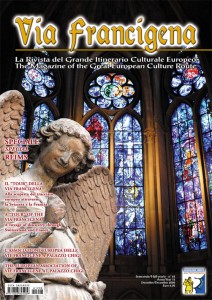 Non solo pellegrini che vogliono sciogliere un voto, ma anche moderni, curiosi turisti saranno interessati a scoprire e percorrere la Via Francigena.
Non solo pellegrini che vogliono sciogliere un voto, ma anche moderni, curiosi turisti saranno interessati a scoprire e percorrere la Via Francigena.
Certamente non tutti i 1700 km che vanno da Canterbury a Roma e che il vescovo Sigerico nel lontano 990 descrisse accuratamente per volere di papa Giovanni XV.
La Via Francigena è appunto questo itinerario medievale che univa il Centro Nord Europa a Roma, luogo del martirio dei Santi Pietro e Paolo, “alla ricerca della Perduta Patria Celeste”. La via doveva essere compiuta, prevalentemente a piedi per ragioni penitenziali, con un percorso di 20-25 chilometri al giorno, ma fu anche una grande via di comunicazione che vide passare eserciti, mercanti e uomini di cultura.
Con le sue tappe fissate da Sigerico in una mappa conservata al British Museum, è stata definita dal consiglio d’Europa nel 2004 “Grande itinerario culturale europeo”, analogamente al cammino di Santiago de Compostela in Spagna.
Il segmento della Via Francigena Morenico Canavesana
 Oggi la Via Francigena si può percorrere a segmenti, scegliendo il percorso più originale, vicino, o accessibile, sicuri che la fatica sarà ripagata. Un segmento particolarmente bello da consigliare è la parte Morenico Canavesana. Nel Canavese, infatti, si trova la 45ma delle 79 tappe dell’itinerario compiuto da Sigerico, l’arcivescovo inglese che descrisse minuziosamente tutto il percorso, annotando in un diario soprattutto i vari punti di sosta.
Oggi la Via Francigena si può percorrere a segmenti, scegliendo il percorso più originale, vicino, o accessibile, sicuri che la fatica sarà ripagata. Un segmento particolarmente bello da consigliare è la parte Morenico Canavesana. Nel Canavese, infatti, si trova la 45ma delle 79 tappe dell’itinerario compiuto da Sigerico, l’arcivescovo inglese che descrisse minuziosamente tutto il percorso, annotando in un diario soprattutto i vari punti di sosta.
Il percorso della Via Francigena Morenico- Canavesana, compreso fra il tratto Valdostano e quello Biellese-Vercellese, si sviluppa lungo 50 km circa attraversando i territori di 10 Comuni: durante il cammino si percorre un bellissimo tratto dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea creato dal ritiro del Ghiacciaio Balteo, una delle conformazioni geologiche di origine glaciale meglio conservate al mondo, punteggiata da laghi e caratterizzata dal lungo profilo della Serra, dorsale morenica di 25 chilometri.
Carema
 Per scendere da nord a sud, si comincia con la suggestiva tappa ancora valdostana di Pont Saint Martin, segnata dal pittoresco ponte a schiena d’asino dove passarono gli eserciti romani. Si entra così in Piemonte a Carema, caratteristica per i suoi vigneti abbarbicati sui ripidi terrazzamenti, da cui si ricava il nobile e raro vino Carema, di color rosso rubino che volge al granato, prodotto solo qui. Caratteristici della zona i pergolati sostenuti dai tupiun, le tipiche colonnette di pietra e mattoni, imbiancate con la calce, che trattengono il calore del giorno per restituirlo dopo il tramonto e che costituiscono l´aspetto più originale del paesaggio.
Per scendere da nord a sud, si comincia con la suggestiva tappa ancora valdostana di Pont Saint Martin, segnata dal pittoresco ponte a schiena d’asino dove passarono gli eserciti romani. Si entra così in Piemonte a Carema, caratteristica per i suoi vigneti abbarbicati sui ripidi terrazzamenti, da cui si ricava il nobile e raro vino Carema, di color rosso rubino che volge al granato, prodotto solo qui. Caratteristici della zona i pergolati sostenuti dai tupiun, le tipiche colonnette di pietra e mattoni, imbiancate con la calce, che trattengono il calore del giorno per restituirlo dopo il tramonto e che costituiscono l´aspetto più originale del paesaggio.
Come in altre piccole tappe pittoresche, anche Carema ha mantenuto un impianto di tipo medioevale, in cui spiccano pregevoli edifici come la Torre degli Ugoni e la Grand Maison, una “casaforte” dalle robuste pareti in pietra in cui si aprono piccole finestre con inferriate, incorniciate da rustici architravi e piedritti.
E medievale sembra anche talora il cammino nei campi, tra case in pietra isolate, torri cilindriche, avamposti turriti di castellotti, qualche volta ridisegnati nell’800 in forme tardo gotiche.
La Pieve protetta dal FAI a Settimo Vittone
 Ci sono però anche veri capolavori persi nel verde. Tra questi sicuramente a Settimo Vittone uno dei complessi architettonici romanici più importanti del Piemonte: la Pieve di San Lorenzo, protetta dal FAI, con pianta a croce latina e pregevoli cicli di affreschi del X-XIV secolo e il Battistero di San Giovanni Battista ancora più remoto, dell’VIII-XI secolo ad abside quadrata e con un campaniletto aggiunto nel XIII secolo. Secondo la tradizione orale il complesso paleocristiano dovrebbe essere sorto sotto gli Anscarici che nel IX secolo reggevano la Marca d´Ivrea e secondo la leggenda, vi sarebbe sepolta la bella ed infelice Ansgarda, figlia di Anscario, moglie ripudiata del re di Francia Ludovico II il Balbo, ritiratasi a meditare in questo luogo. All’interno della chiesa e lungo le pareti del corridoio che porta al battistero si trovano, in maniera alquanto “disordinata”, vari affreschi: frammenti del Giudizio Universale, San Michele Arcangelo che pesa le anime, San Cristoforo con in mano, forse una palma con datteri, il Miracolo di San Nicola di Bari ed una Adorazione dei Magi con una Madonna che tiene in mano uno stranissimo fiore. La parte meglio conservata degli affreschi è nella piccola cappella destra del presbiterio: un Cristo benedicente con una folta barba bianca, le figure del “Tetramorfo”, fatto dai simboli dei Quattro Evangelisti.
Ci sono però anche veri capolavori persi nel verde. Tra questi sicuramente a Settimo Vittone uno dei complessi architettonici romanici più importanti del Piemonte: la Pieve di San Lorenzo, protetta dal FAI, con pianta a croce latina e pregevoli cicli di affreschi del X-XIV secolo e il Battistero di San Giovanni Battista ancora più remoto, dell’VIII-XI secolo ad abside quadrata e con un campaniletto aggiunto nel XIII secolo. Secondo la tradizione orale il complesso paleocristiano dovrebbe essere sorto sotto gli Anscarici che nel IX secolo reggevano la Marca d´Ivrea e secondo la leggenda, vi sarebbe sepolta la bella ed infelice Ansgarda, figlia di Anscario, moglie ripudiata del re di Francia Ludovico II il Balbo, ritiratasi a meditare in questo luogo. All’interno della chiesa e lungo le pareti del corridoio che porta al battistero si trovano, in maniera alquanto “disordinata”, vari affreschi: frammenti del Giudizio Universale, San Michele Arcangelo che pesa le anime, San Cristoforo con in mano, forse una palma con datteri, il Miracolo di San Nicola di Bari ed una Adorazione dei Magi con una Madonna che tiene in mano uno stranissimo fiore. La parte meglio conservata degli affreschi è nella piccola cappella destra del presbiterio: un Cristo benedicente con una folta barba bianca, le figure del “Tetramorfo”, fatto dai simboli dei Quattro Evangelisti.
Gli originali balmetti di Borgofranco
Se il tempo lo permette, poi, si può percorrere un’antica mulattiera per raggiungere lo scenografico Castello di Montestrutto, ricostruito in stile neogotico alla fine dell’800 sui resti di un fortilizio medievale e affiancato dalla chiesetta romanica di San Giacomo.
Le attrazioni culturali si alternano a punti di interesse paesaggistico. Ad esempio nella zona di Borgofranco d’Ivrea sono davvero originali i Balmetti, che, come i “crotti” valtellinesi, sono cantine naturali ricavate negli anfratti della montagna, caratterizzate da una corrente d’aria naturale a temperatura costante di 6-7 gradi, in cui si conservano vino, formaggi e salumi.
La splendida Ivrea
 Tra laghi balneabili, falde di colline moreniche, cascine a loggiati affacciate su cortili interni, si arriva finalmente a Ivrea, la romana Eporedia e la medioevale Yporegia, che ha rivestito da sempre un importante ruolo strategico. Pittoresca, affacciata sulla vorticosa Dora Baltea, Ivrea presenta una parte alta, in cui sorge la Cattedrale di Santa Maria, voluta dal Vescovo Warmondo (969-1005) sulle vestigia di un tempio romano: conserva molti degli elementi romanici originali, come la cripta con affreschi del XI-XIII sec., i campanili, il tiburio e l’esterno dell’abside, accanto alla quale si possono vedere i resti del Chiostro dei Canonici.
Tra laghi balneabili, falde di colline moreniche, cascine a loggiati affacciate su cortili interni, si arriva finalmente a Ivrea, la romana Eporedia e la medioevale Yporegia, che ha rivestito da sempre un importante ruolo strategico. Pittoresca, affacciata sulla vorticosa Dora Baltea, Ivrea presenta una parte alta, in cui sorge la Cattedrale di Santa Maria, voluta dal Vescovo Warmondo (969-1005) sulle vestigia di un tempio romano: conserva molti degli elementi romanici originali, come la cripta con affreschi del XI-XIII sec., i campanili, il tiburio e l’esterno dell’abside, accanto alla quale si possono vedere i resti del Chiostro dei Canonici.
Al suo fianco si erge l’imponente Castello “dalle rosse torri”, citato da Carducci: “Ivrea la bella / che le rosse torri specchia / sognando a la cerulea Dora / nel largo seno, / fosca intorno è l´ombra di re Arduino.”
Sull’altro lato della piazza il Palazzo Vescovile mostra ancora alcune caratteristiche della casaforte medioevale: il Torrione del Vescovo, i merli a coda di rondine, i fregi e le spesse mura.
Scendendo lungo l’antico decumano romano si giunge nella Piazza del Municipio, dove si può ammirare, sulla facciata della Chiesa di Sant’Ulderico, il fronte del campanile romanico: secondo la tradizione, nel 971 il vescovo tedesco avrebbe compiuto un miracolo proprio in questo luogo. Proseguendo verso il lungo Dora si incontra il Campanile di Santo Stefano, unica testimonianza dell’antico complesso abbaziale benedettino fondato nel 1044 e abbattuto a metà del XVI sec.
Mentre si cammina si fa amicizia, si conoscono stranieri venuti da lontano, si ascoltano racconti del passato, si scoprono persone indimenticabili e sapori autentici e genuini. Tra i vini, i famosi DOC Carema, Canavese, Erbaluce e Passito di Caluso. Tra i cibi, saporite zuppe, piatti a base di funghi, castagne e cipolle, insaccati e formaggi tipici e una grande varietà di golosi dolcetti. Da consumare sul posto o da portare via nello zaino del pellegrino!
Informazioni Utili:
info.torino@turismotorino.org – info.ivrea@turismotorino.org
Associazione Via Francigena Canavesana di Sigerico, Valter Anselmo tel. 329.2160882 – 334.3165250 francigenasigerico@tiscali.it
Per dormire, a Ivrea Hotel Sirio, affacciato sul lago, info@hotelsirio.it – http://www.hotelsirio.it/
A Borgofranco d’Ivrea raccomandata una sosta alla Bottega del Canestrello, bottega.canestrello@libero.it
Per una pausa gastronomica il Ristoro Vertical Rock in Frazione Montestrutto, Tel. 348.4073610 bertino.ilario@tiscali.it
Per una sosta golosa la pasticceria Balla in Corso Re Umberto 16 a Ivrea con la famosa esclusiva Torta 900.







